10 Maggio 2021

Angelo Crespi
Molte e condivisibili le riflessioni di Angelo Crespi, professore che scrive in maniera comprensibile un libello in forma di intervista dotta, di facile lettura, che vista la complessità dell’argomento già meriterebbe considerazione. L’autore vuole forse un mondo migliore che passi per l’arte e per la sua bellezza, e che quindi contribuisca allo sviluppo di un sentire comune che migliori la società, che le opere d’arte contemporanea inoltre esprimano i valori economici che effettivamente rappresentano, vuole che esista un criterio oggettivo per riconoscere la bellezza, vuole che il mercato consideri appetibili anche opere poco costose. Così sorge spontaneo un dubbio, nato dal fatto che i peggiori delitti sono animati dalle migliori intenzioni... "Se le realizzazioni plastiche dell’Unione Sovietica sono, come è stato più volte notato, simili a quelle care a Hitler sotto il Terzo Reich, questo non è dovuto all’ironia della Storia: il sistema estetico che le sottende è identico e attinge alle stesse fonti".
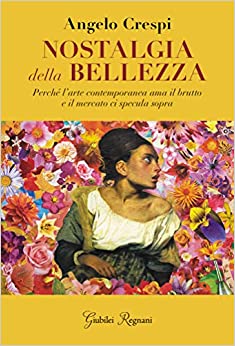
Così Jean Clair nella sua famosa Critica della modernità negli anni ‘80 metteva una pietra tombale sul 'classicismo', e forse sulla bellezza così come la intende il prof. Crespi nel suo Nostalgia della bellezza perché -anche se prende distanze spesso da una prefissata idea di stile- leggendo il testo ovviamente viene il dubbio che la bellezza in questione non possa che essere figurativa, tradizionale e ‘realista’, se non ‘politicamente corretta’, sicuramente ‘fatta bene’, vicina alla ‘perfezione’ e comunque artigianale. Forse a sprazzi ricordando il nulla di Baudrillard (La sparizione dell’arte, 2010) o il cronista Thompson (Lo squalo da 12 milioni di dollari, 2008), o il suo precedente Ars Attack, il bluff del contemporaneo, ed. Johan e Levi, 2013 (argomenti trattati anche da ‘Senza arte né parte’, 2013 e ‘Ridateci la Gioconda’, 2014 editi da Pagine, i libri del Borghese); l'autore non vuole perdersi nel senso che in fondo è proprio quello dell'identità dell’arte contemporanea, quello dell'iper-metaforicità (termine coniato da Luisa Muraro), ossia quella di trattare su tutto liberamente ai massimi livelli; contrariamente abbiamo appunto design, artigianato, decorazione e una inedita ‘bellezza’ riconosciuta nelle arti minori. Sebbene sia necessario auspicare che, come scrive Crespi: “... ci salverà la pittura che è l’unica vera avanguardia, ci salveranno quegli artisti che dipingono e scolpiscono fidandosi delle loro mani, mirando alla perfezione, credendo di poter ancora produrre capolavori”, e presumiamo già avvenga per molti artisti incompresi (non solo che producono opere belle ma anche brutte e che scrivono anche) potremmo rivalutare la ‘bellezza’ e i desiderata dell’autore, -soprattutto rispetto all’arte-escremento- ma potremmo anche dire dell’arte minimal-sbrattata, vomitata o action painting de noantri, ‘sgunz’ (come la definisce l’autore) e rispetto a certe installazioni da ultima Biennale, considerate in maniera ambivalente, come fa con Ai Weiwei, reo di usare salvagenti nelle sue installazioni, un po’ sorde e ripetitive, pretestuose rispetto gli eventi di cronaca. Ma come succede per il vero barcone in cui morirono 700 migranti che Büchel espone alla biennale, o il relitto del dc9 di Ustica in cui ne morirono 81 di civili, allestito al Museo per la memoria di Ustica a Bologna da Boltanski- forse in queste ultime troviamo più senso, che non avrebbero avuto se fossero state dipinte su tela, magari copiando da foto. Il lettore arriva a chiedersi cos’è la pittura e come si misura una correttezza dell’arte o una sua perfezione o se il concettuale sia arte, quando a queste domande abbiamo risposto da tempo, perché è inutile pensare che il David o il Giudizio Universale di Michelangelo siano ancor oggi pietre di paragone per valutare l’arte contemporanea. Scrive ancora Crespi: “Io però preferisco parlare di “perfezione”, intendendo il termine perfetto nel suo senso etimologico, da perficio, di “portato a termine”. Quando l’opera d’arte è perfetta, cioè è portata a termine nel modo che doveva essere portata a termine, allora risplende la bellezza, perché nulla si può aggiungere o togliere senza che se ne accresca inutilmente o peggio se ne diminuisca l’insieme. Non è dunque la bellezza dell’oggetto rappresentato a fare bella l’opera, ma il modo in cui è rappresentato, cioè la forma. In questo senso l’arte visiva, attraverso la compostezza della forma e il suo risplendere, non solo in senso apollineo ma anche dionisiaco, può perfino rappresentare il brutto o il mostruoso emendandoli”. Ma -si potrebbe obiettare- c’è da discutere sull’utilità di escrementi o di corpi in decomposizione nell’arte; ci sovviene Baudelaire quando si imbatte in una carogna nel bosco, o scene dell'Iliade; nel ‘De immundo’(2005) di Jean Clair, veniamo a riflettere su come gli escrementi, compresa la cosiddetta Merda d’artista, non solo diano il nome a un’opera di Manzoni degli anni ‘60, ma che vi sia una lunga letteratura a riguardo; sia Dante Alighieri nella Divina Commedia che Primo Levi ne parlano: probabilmente è proprio il ‘bello’ che viene messo in discussione soprattutto se ha a che vedere con la perfezione o la purezza o ancora, con la presunta superiorità. Per non parlare del colore, che in questo caso è la ‘terra’ che la modernità con l’impressionismo rigetta. Spezzando una lancia per Crespi, uno dei pochi a chiedere di tenere aperti i musei anche durante il lockdown (dapprima dichiarati servizi essenziali dal ministro Franceschini) e ad attaccare la 'cancel culture', dobbiamo però tornare a citare Paul Valery quando scrive: “Si può descrivere un cappello in venti pagine, una battaglia in dieci righe” cosa che suona come una delle leggi della Gestalt: “Il tutto è più della somma delle singole parti”. Nella storia dell’arte - che non è la storia della rappresentazione degli oggetti- è importante pensare che soprattutto nel quadro non vi siano solo alberi, nudi, case e paesaggi ma la negazione di quest’ultimi, perciò se non si è scolari è perfettamente inutile contemplare la pittura di un paesaggio; Cézanne -e i suoi eredi concettuali- con la sua quantità di negazioni, avrebbe molto a che vedere anche con lo ‘Zen’ e la cosiddetta ‘Illuminazione’, quella che ha riscoperto l’arte per il tramite di simulacri, che trasmutano un mondo fatto di materia più pesante, “la stessa del corpo dell’autore” come scrive Merleau Ponty. Ultimamente Vittorio Sgarbi ha messo in discussione la bellezza dei sacchi di Burri, o dei tagli di Fontana (momenti di attesa), probabili ‘lacerazioni’ per dirla alla maniera di Umberto Eco, o altre opere in cui qualche volta -come nei quadri di Rothko- ci specchiamo come fa ‘un bambino nel volto della madre’ (cit. Winnicott). Sembrerebbe un errore il revisionismo dell’arte contemporanea, per la ricchezza di letture che ne dilatano i sensi ma a ragion veduta oggi Crespi riconosce una superfetazione delle critiche che accompagnano le opere o una coazione a ripetere del momento dissacratorio e destabilizzante del primato dovuto a Duchamp a inizio ‘900, di esporre oggetti industriali come orinatoi, pettini, ampolle senza alcun valore se non un titolo scherzoso. E’ così che le tante cacofonie del contemporaneo si moltiplicano alla ricerca di bellezza che sicuramente è impossibile riconoscere con oggettività, viste le premesse. Se poi il nostro prossimo, agonizzante nelle acque del mediterraneo è alla stregua di materia inerte, è chiaro che il cerchio si chiude: siamo chiamati ad esporre barconi e carcasse di aerei, sintomi di olocausti attuali da contrapporre allo stucchevole coniglio zincato di Jeff Koons o alle altrettanto zincate industriali realizzazioni di Anish Kapoor. Le opere conserverebbero così un pò di autonomia, quando non sono altro che appendici di corpi umani, e quindi considerandole alla pari di escrementi seppur in maniera innocua, non si fa altro che etichettare i loro autori di cui ci rimane l’impronta; è pur vero che la confusione nei musei è tanta e spesso disarmante, perché in fondo il problema è che l’alterità è stata preferita alla bellezza, a cui si aggiunga la contingente capacità di collezionisti e investitori stranieri di determinare -partecipando alle aste- il mercato dell’arte mondiale: ma quelli italiani che fanno? Nomi di artisti anglosassoni si sono succeduti a Roma a Bologna, a Milano, a Napoli incessantemente, prima della pandemia, tanto da portare autori al pari di Crespi a denunciarne il monopolio da anni. Hirst a Venezia e prossimamente alla Galleria Borghese di Roma, non è che l'apoteosi di un enorme nauseante grand tour dello strapotere delle gallerie multinazionali di Pinault, Gagosian, Saatchi, che già imperversano con i loro programmi avulsi dal paesaggio italiano; e quindi su Hirst, Crespi non ha altro che ragione. Ma per dire ‘basta’ ci vogliono investimenti statali massicci, altro che teorie estetiche sul ‘bello’ o tentativi di voler dichiarare 'finita' la modernità che invece è per suo stessa definizione 'non finita', erronea, brutta, ambigua. Michelangelo, Cézanne, Leonardo, Picasso cercavano la verità a tentativi, facendo errori continui. Errori visibili a occhio nudo anche nei quadri di Velasquez, Caravaggio, Matisse, Rubens, Mondrian. Quello che sospettiamo è che non ci sia mai stata interruzione in questa storia e che la ‘bellezza’ così come viene teorizzata dai classicisti sia solo un episodio nella storia dell’arte, che è invece una continuità di narrazioni autobiografiche, a volte riconosciute scandalose dalle comunità in cui si sono sviluppate; esperienze non comuni come quella di Piero Manzoni tanto per intenderci, oppure potremmo scomodare la pittura di Goya, Bosch o Cranach, diametralmente opposte alla pittura del rinascimento italiano e sotto certi aspetti: ‘brutte’. Attualmente è la bruttezza ad essere molto ricercata perchè la censura è molto forte e la classe dominante è ‘bella’ ossia ricca, benestante e sovraesposta: inoltre non possiamo permettere che la spartizione di argomenti culturali per il tramite della dicotomia sovranismo-tecnocrazia, vada a collocare il 'realismo' (considerato ‘democratico’ da Crespi), appunto nell'area sovranista, come stile più vicino alla pancia del Paese, comprese opere 'ben fatte', perché di immediata comprensibilità; mentre tutte le altre manifestazioni dell’arte verrebbero attribuite a un’egemonia straniera. Né ci convince paragonare la Ferragni alla Venere di Botticelli, come ha fatto Schmidt, il direttore degli Uffizi. C’è piuttosto l’incapacità politica di far rispettare gli artisti autoctoni se vale il ‘prima gli italiani’ (come la ‘Cancel culture’ che abita da quelle parti) che sembra sempre più un motto vuoto e senza senso, come la ‘buona politica’, se pensiamo che anche in precedenza l’Italia non riusciva a cimentarsi con serietà nel mondo dell'arte contemporanea. Il libro di Angelo Crespi -che io personalmente consiglio a tutti- va comunque riconosciuto come pietra angolare dell’interprete -forse massimo esponente- di una grande condivisa insoddisfazione attuale, ma senza la pretesa di aver risolto un problema che con gli stili ha poco in comune, visto che i maggiori responsabili si trovano altrove.
Il Giornale d'Italia è anche su Whatsapp. Clicca qui per iscriversi al canale e rimanere sempre aggiornati.
Articoli Recenti
Testata giornalistica registrata - Direttore responsabile Luca Greco - Reg. Trib. di Milano n°40 del 14/05/2020 - © 2025 - Il Giornale d'Italia